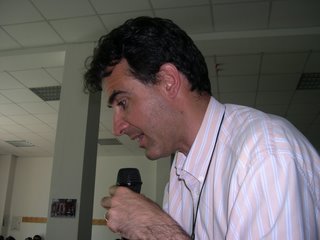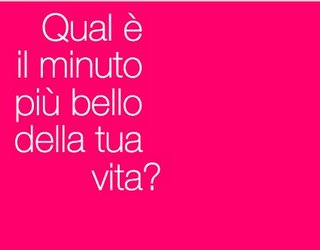Approfondiamo il ragionamento che ho provato a delineare in un mio
post precedente e che sembra avere sollecitato in giro qualche riflessione (come quelle di
Roberta)
Il dibattito, necessario e serio, sulla realtà dei blog non può prescindere dalla distinzione tra funzione e forme dei blog da una parte, e natura atropo-sociale del bloggers dall’altra.
Il contesto è, ovviamente, più ampio. Mi limito però qui a dire: dobbiamo pensare che per un verso abbiamo a che fare con un fenomeno sociale che “fa” società e che per l’altro verso abbiamo a che fare con gli individui e con il contesto comunicativo e di socializzazione mutato dalla presenza di ambienti mediali. Ci sono dunque implicazioni di portata sistemico-mediale dovute alla proliferazione di mezzi di massa a portata individuale e collettiva. E poi ci sono gli individui.
Si tratta di solitari solipsisti impermeabilizzati nelle relazioni grazie alle forme a distanza?
Oppure di tecnoconnettivisti ad alta densità di relazioni sociali che pluralizzano le identità nei diversi ambienti reali/artificiali sperimentando la complessità del vivere oggi (la vulgata di SecondLife stile “pariolini” docet: leggersi
pezzo di Ammanniti su XL)?
Quello che mi interessa sono i percorsi interpretativi che tengono in considerazione una sospetta dinamica di desocializzazione connessa alle pratiche relazionali mediate.
I quasi 120 milioni di abitanti di MySpace e quelli di piattaforme simili di social network, perlopiù giovani, mostrano il mutamento culturale che pervade la rete oggi. Si è in contatto con gli altri anche per via mediata, grazie alle forme di distanza a pratiche culturali e partecipative che si costruiscono attorno ad attività discorsive mediate tecnologicamente. Meno chiacchiere al bar e più in rete, meno turbamenti emotivo-corporei sulle panchine dei giardini e più Messenger, cose così.
Bifo, da sempre attento alle psicopatologie della seconda vita quotidiana, la pensa così:
Altro che social network, in realtà si tratta di una pratica che cancella la socializzazione, o piuttosto (io credo) si tratta di una pratica che risponde al bisogno di desocializzazione. Il contatto, la presenza, la vicinanza diventano sempre meno sopportabili per la generazione che ha imparato più parole da una macchina che dalla mamma, per bambini che non hanno frequentato bambini, e sono cresciuti attaccati a un mediatore di socialità.
I “mezzi di comunicazione di massa per le masse” diventerebbero mezzi di riproduzione di massa delle masse. Le pratiche di mediazione della socialità preludono ad una società fondata sul distacco fisico e sulla mediazione emotiva delle macchine. L’accento, insomma, è sull’effetto di desocializzazione.
Desocializzazione. O, piuttosto, iper-socializzazione,? - che è come dire: de-socializzazione per eccesso di socialità: diretta e mediata, della prima e della seconda vita.
Ma non dovevamo dimenticare – dopo Foucault anche – Baudrillard?
La riflessione teorica è simile a quella che caratterizza il procedere analitico del sociologo francese. La sua iperrealtà era l’idea di iper-realizzazione del mondo e il conseguente svuotamento di senso ed uccisione della realtà per eccesso. Ricordate il
Delitto perfetto?
Se c’è morte del reale non è per sottrazione ma per un eccesso di realtà, eccesso che si produce per mezzo delle nuove tecnologie e dei media (l’arma del delitto, naturalmente priva di impronte). I media operano una "trasfigurazione tecnica del mondo", lo esauriscono nel realizzarlo, ne attivano "il codice di sparizione automatica". Siamo di fronte:
solamente alla dilatazione del corpo morto del reale – proliferazione di un universo compiuto, al quale non resta che iperrealizzarsi a non finire
Sarebbe perfetta, dunque, come tattica complessiva di svuotamento di senso sistemico per eccesso di senso corporeo, quello prodotto “dal basso”: dal proliferare di micro informazioni spesso insignificanti, utili più per se che per gli altri, devianti e deflagranti, miscela di ironia e stupidità; semplice caricamento di immagini con gatti e cani da condividere; produzione di lettere alfabetiche per Messenger da esibire agli amici in sequenze grafiche di puro senso estetico; eccesso di accessi in SecondLife di curiosi “avatar per un giorno” utili a gonfiare statistiche che portano imprese diverse dentro un mondo con utenti sempre unicamente possibili ma poco attualizzati …
Ipersocializzazione come pratica virale che nel proliferarsi di comunicazioni prodotte, riprodotte, diffuse, copiate e incollate, podcastate, ecc. porta all’implosione del senso.
Il tutto senza operazioni di mediattivismo dichiarato ma solo attraverso il puro utilizzo mediale da parte degli utenti di entrambi i lati della coppia produzione/consumo: il farsi media, insomma.
La pratica quotidiana che si fa politica. Le comunità di pratiche che producendo dissolvono.
Ma stanno così le cose?
C’è la questione dei corpi, di come sapere e vita si relazionano e vengono combinati negli ambienti mediali.
La televisione e i media virtuali mobilitano
costantemente il sistema nervoso sottraendo spazio per la socializzazione, per lo scambio affettivo, per la corporeità. Linguaggio e affettività sono scissi in maniera patogena.
Sul lato dei corpi, laddove l’effetto di cumulabilità delle pratiche del collettivo è solo rumore di fondo, la dimensione affettiva e, in fondo, l’esperienza, si costruisce attorno ad un linguaggio che è sempre più disancorato dal vissuto corporeo – così si dice. Nei media – territori, ambienti, mondi – la cui sostanza “materiale” è la comunicazione, impariamo ad interagire e a costruire vissuti emotivi a partire dalle conversazioni, dalle interazioni fra avatar, ecc. Quale forma corporea è questa? In che modo è desocializzante? Lo è perché la corporeità implicata è mediata? Ma allora: esiste un vissuto che non sia in qualche modo corporeo? Un’esperienza che non rientri, poi, nella processualità sensoriale? Tutta la dimensione della relazione fra media ed erotismo qualcosa dovrebbe avercelo insegnato.
Allora è desocializzante perché se chatti con altri non ne senti gli odori, non ne vivi la consistenza?
Eppure nelle giovani generazioni i segnali della necessità di problematizzare la socialità all’epoca della mediazione esiste.
C. ha 12 anni, viene a casa da scuola e mangia in fretta perché con i suoi compagni si è data appuntamento in Messenger. Magari con la webcam. Li fà esperienza dei rapporti che vive nella prima vita quotidiana in altro modo. Vale la pena riflettere.